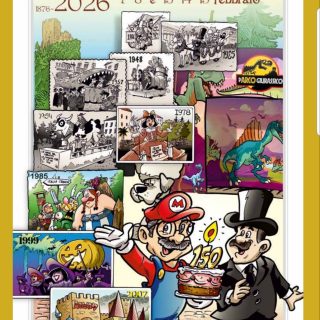Gamberéta, l’indovina dalla gamba di legno che vestiva di bianco

“C’era una volta”, così iniziano le fiabe.
E, dunque, c’era una volta, in una Riva che si beava di misteri e leggende, una donnina, “piccina piccina picciò”, che davvero ricordava quella delle filastrocche della nonna. Si chiamava Gamberéta. Oh, sul nome, dirvi di più non so. Vi basti sapere che tutti la chiamavano così: Gamberéta. E che, ancora oggi, ad una settantina d’anni dai suoi tempi beati quel nome, di tanto in tanto, torna nell’aria a riscaldare una memoria cittadina sempre più evanescente. Ma c’è ancora qualcuno che resiste e così la evoca. Soprattutto per quel suo vezzo indimenticabile di andarsene a zonzo sempre vestita di bianco. Immacolata, camminava per le vie del centro nella sua personale nuvola candida. Sempre, ma davvero sempre. Incurante sia degli sboffi d’aria bollenti dell’estate che dei rigori del gelo invernale.
Gamberéta, la bianca dama dei poveri. Viveva in una vecchia casetta, di certo piccina piccina picciò, in pieno centro storico. Proprio nei pressi dell’albergo Alpino.
Non solo erano bianchi e immacolati i suoi vestiti, tra i quali s’imponeva per civettuola leggiadria una sorta di tunica da vestale, ma bianca era anche la cuffietta che teneva in testa nelle stagioni delle calure, come bianco era il vezzoso cappellino invernale.
Dama dei poveri, dalla testa ai piedi. Visto che perfino le scarpe, che erano da ginnastica, erano di un bianco, a dirla tutta, un po’ provato dallo struscio quotidiano.
Minuscola di statura era claudicante. Per via di una gamba di legno che la costringeva a muoversi appoggiandosi ad un bastone, Bianco e pure di legno, ci mancherebbe.
Finito con i malanni fisici? Neanche per sogno, perché la Gamberéta aveva, oltre alla gamba di legno, anche la gobba. Ma dai…
Oh, non sto inventando niente, sia chiaro. Leggete la commovente poesia in dialetto che le dedicò lo stimato professor Luciano Baroni e troverete anche la gobba.
A dispetto dei suoi mali fisici la Gamberéta muoveva, con leggiadra fatica, faticosi passi scanditi dal ticchettio del bastone sul selciato. Era sempre a posto, pulita. Aveva dignità da vendere, alla faccia delle gran signore. Copriva le rughe con belletto e cipria, usate senza risparmio. Si muoveva così, come portata in trionfo, nel bel mezzo di una nuvola di vaporoso profumo.
Non chiedeva l’elemosina, ma teneva in tasca un mazzo di carte da tarocchi. I rivani, soprattutto quelli che avevano bottega nelle vie del centro, la invitavano ad entrare. Un po’ per scherzo, un po’ perché intimoriti dall’alone di mistero che emanava. In cambio di un obolo, di un panino con la mortadella o di un paio di cavoli, si facevano predire il futuro. Lei, con fare solenne, sparpagliava le carte sul bancone. E, da santa indovina dalle parole incomprensibili come quelle della sua antenata, la Sibilla Cumana, vaticinava. Cioè faceva dono ai suoi “clienti” di profezie, sempre felici e consolatrici. Proprio quelle che loro si aspettavano. Bene i figli, affari da nababbi. E la salute? Ottima e abbondante.
Donava, con le sue buone profezie, serenità ed allegria. Il Fiorello della bottega di pane e latte di via Disciplini ogni mattina, carte o non carte, le assicurava una santa colazione. Poi, tutto gratis et amore Gamberéta: il caffè in un bar, un regalo in un’altra bottega e la sosta, di dovere e piacere, ai banchi di frutta e verdura di piazza Erbe. Andava in estasi per i colori della frutta. Si chinava, la gobba consegnata all’aria, e annusava estasiata verdura e fiori. Gli occhi, che teneva di un bell’azzurro, allora si illuminavano. E le luci, tutt’attorno, si accendevano.
Capitava poi che i ragazzini, si sa come vanno le cose, la prendessero in giro. E dire che non era una strega. Ma un angelo bianco, sceso in incognito su questa terra.
Vittorio Colombo